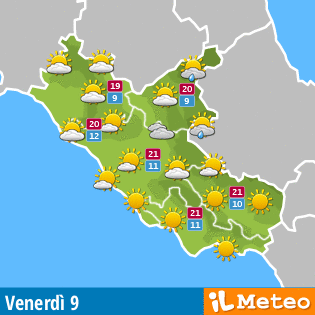PHOTO
Sabato 2 agosto 1930, novantatre anni fa, La Stampa di Torino pubblicava un articolo intitolato “SPIAGGE ROMANE – Quando i bagni di mare non erano di moda”. È firmato da Diego Angeli (1869-1937), giornalista e fine letterato che si forma nell’ambiente culturale romano di fine Ottocento dominato dal giovane e brillante Gabriele d’Annunzio. Nei suoi scritti, scrive lo storico Danilo Veneruso, che curò la sua scheda sul Dizionario Biografico degli Italiani (volume 3, 1961), “si avvertiva la presenza di una zona singolarmente vasta del sapere, associata con una rara e sorprendente preparazione”. Collaboratore di diversi giornali, approdò alla Stampa nel 1926.
Nell’estate del 1930 fu inviato sul litorale romano per scrivere dei corsivi sulle località marine frequentate dagli abitanti della Capitale. Ne dedica uno a Civitavecchia, un altro a Santa Marinella.
Nell’elzeviro dedicato alla “città d’incanto che a tutti piace tanto”, tratteggia con maestria e qualche errore storico (il primo stabilimento balneare a Civitavecchia è degli quaranta dell’Ottocento) i fasti e la veloce decadenza di Civitavecchia come stazione balneare. Ricorda i tentativi degli Odescalchi e dei Guglielmi di proiettare la cittadina portuale come realtà turistica ma con scarso successo. Alla fine il Pirgo, stabilimento frequentato dall’aristocrazia e dalla ricca borghesia capitolina abbandona il lido civitavecchiese per altre destinazioni meno inquinate dal carbone portuale e non seviziate dal passaggio dei treni che interrompono la tranquilla passeggiata dei villeggianti.
Lo scritto di Diego Angeli ci restituisce angoli e momenti felici della vita ottocentesca di Civitavecchia: le baracche dove si vendevano i ricci e si beveva il vino di Tolfa; gli spaghetti che le osterie offrivano ai romani in gita; i manifesti affissi a Roma che invitavano i cittadini capitolini a trascorrere le vacanze a Civitavecchia, ed altro ancora.
“Col mare a quindici chilometri dalle sue porte, Roma ha tardato più di ogni altra città italiana a mettere in valore le sue spiagge. […]
Si può dunque dire che una vera e propria stagione balnearia cominciò a Roma soltanto dopo il 1870 e fu proprio Civitavecchia ad iniziarla. Dire che quella città fosse molto adatta ad un simile ufficio, sarebbe forse esagerato. Mancanza di una vera e propria spiaggia – prima di tutto.
La costiera, in quel punto è come un seguito di dune scarpate, che scendono a picco sul mare; e il mare è sassoso e turbolento. Magnifico per i pittori, quel paesaggio, così selvaggio e fragrante d’erbe aromatiche; mentastro e rosmarini, ginepri e tamerici, che il vento del largo piega nelle fogge più strane, e l’aria salsa brucia colorandole come di un colore ramigno. D’estate poi è un grande rutilare di ginestre, un manto d’oro che per intieri chilometri fiammeggia senza interruzione sull’orlo delle dune e mette il contrasto delle sue note luminose, contro l’azzurro metallico dell’acqua sottostante. Ma tanto è bello il paese per i poeti e per i pittori, altrettanto è poco adatto per i bagnanti, che non trovano una spiaggia buona e debbono contentarsi di qualche piccola insenatura, tutta cosparsa di ciottoli rotondi e di scogli, nelle cui buche si annidano i ricci marini e le arselle. La quantità dei ricci è anzi così grande che nei mesi di primavera si costruiva lungo la spiaggia una quantità di baracche dove i clienti, pagando la piccola somma di due soldi, potevano mangiarne a discrezione. Si pagava – è vero – il vino: ma anche quello non era caro e con venticinque o trenta centesimi la foglietta – una foglietta equivale a un mezzo litro – ci si poteva ubriacare allegramente con quel vinello dei vicini monti di Tolfa, alcoolico e solfureo come le terre vulcaniche su cui erano nate le vigne che lo producevano.
Il porto dello Stato pontificio
All’inconveniente della spiaggia, bisognava aggiungere quello della città: Civitavecchia era stata per secoli l’unico porto importante dello Stato pontificio. È qui che facevano scalo i piroscafi francesi ed inglesi, carichi di ogni sorta di mercanzia e – quel che è peggio – di carbone. È anche qui che lo Stato aveva il suo ergastolo e il suo porto militare, protetto da una magnifica fortezza dovuta alla geniale architettura di Michelangelo. Ma questi privilegi bellici e commerciali avevano trasformato l’antica città romana di Centumcellae in un vero e proprio emporio marinaro con tutti gl’inconvenienti e anche tutto il sudiciume che in questi casi è inevitabile. […]
Il Pirgo
Terzo inconveniente grave – per una spiaggia balneare – fu la ferrovia litoranea: quella ferrovia che per essere una delle grandi linee internazionali – metteva e mette tutt’ora in comunicazione Roma con Genova e con la Francia – era sempre ingombra di treni d’ogni genere; sia i grandi espressi per i passeggeri, sia i merci che servono al commercio di mezza Italia. E questa ferrovia taglia la città dalla sua spiaggia, così che perfino la passeggiata a mare è continuamente offuscata dal fumo delle locomotive e assordata dal fracasso dei treni. Con tutto ciò, e forse anche per tutto ciò, la ferrovia doveva essere una delle ragioni per le quali si cercò di creare a Civitavecchia la spiaggia marittima di Roma. Un imprenditore audace immaginò di creare una specie di stabilimento con rotonda che chiamò classicamente Il Pirgo dal nome antico della località. Un altro, sulle antiche terme ferruginose costruì un primo albergo. Qualche proprietario dei dintorni – come il principe Odescalchi o il marchese Guglielmi – spinse il coraggio fino a edificare qualche villino, per sé e per quelli che avrebbero voluto acquistarli in seguito. E fu così che sessanta anni fa nacque la stazione balneare di Civitavecchia che ad ogni principio di stagione gli ingenui manifesti cromolitografici del vecchio Marchetti – e anche questi erano una novità – raccomandavano al pubblico di Roma come la delizia di tutte le delizie estive. Ricordo ancora taluni di questi manifesti, dove una bella signora – molto opulenta nelle anche e nei seni come voleva la moda d’allora – sorrideva dietro l’ombrellino dai colori violenti, mentre sullo specchio dell’acqua una serie di bagnanti di ambo i sessi si tuffava allegramente fra le spume marine. Questo per i più idealisti: per gli altri, si vedeva in un angolo un cameriere in maniche di camicia che portava grandi piatti di spaghetti fumanti e grandi litri romaneschi colmi del loro vinetto d’oro. Perché allora non si poteva concepire una gita a mare senza la tradizionale spaghettata e l’inevitabile sbornia del ritorno.
L’abbandono.
Questa vita balneare civitavecchiese durò qualche anno. Un po’ artificiosamente, s’intende: per la buona volontà di qualche signore romano che per far piacere al principe Odescalchi andava a passare qualche tempo su quelle spiagge. E anche perché – in quei tempi senza automobili – Civitavecchia aveva il privilegio di una grande linea ferroviaria che in un’ora e mezza poteva condurre da Roma i viaggiatori. E poi Civitavecchia era una città organizzata: aveva un bel teatro, aveva un buon albergo, aveva una quantità di caffè e di negozi che facilitavano la vita balneare. A leggere oggi le corrispondenze mondane di quella spiaggia – e notate che perfino l’allora grandissimo Gandolin non sdegnava di prestare la sua prosa e i suoi pupazzetti per celebrare le glorie del Pirgo – c’è da credere veramente che quella fosse una spiaggia sul serio.
Ma in fondo era come un riflesso di spiaggia che viveva una vita artificiale. E in fondo tutti capivano che non sarebbe durata a lungo. I villini, che già cominciavano ad apparire lungo le dune piantate di lentischi, si fermarono a un tratto. Il Pirgo fu abbandonato. L’alta mondanità aristocratica abbandonò quella spiaggia per altri lidi. La borghesia ricca la seguì per spirito d’imitazione, e la piccola borghesia continuò per un anno o due ad annidarsi nelle povere camere ammobiliate messe a sua disposizione, finché anche lei trovò che si poteva andare altrove con minore spesa e minore disagio.
E il Pirgo rimase per i civitavecchiesi. E le baracche lungo le dune continuarono ad offrire i loro ricci marini a discrezione e il loro vinetto solforoso, mentre la città attivava il suo ritmo commerciale e ritornava nella sua sonnolenza come ai bei tempi in cui il grande Stendhal, console di Sua Maestà Luigi Filippo re dei Francesi, vi esercitava così amabilmente – a dire del De Musset – la sua sinecura la quale, invece, fu per lui una cura gravosissima che doveva condurlo alla morte.
Ma questo è un altro capitolo della storia di Civitavecchia”.
La lettura di questo articolo di novantatre anni fa potrebbe essere particolarmente utile anche oggi.
©RIPRODUZIONE RISERVATA