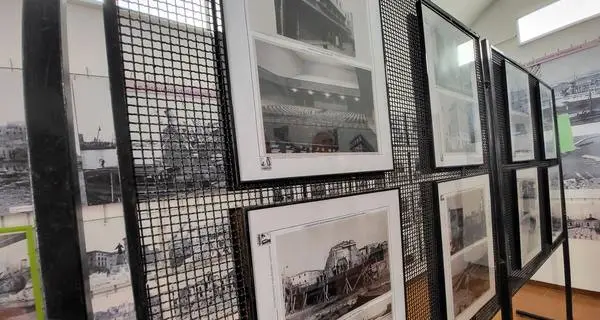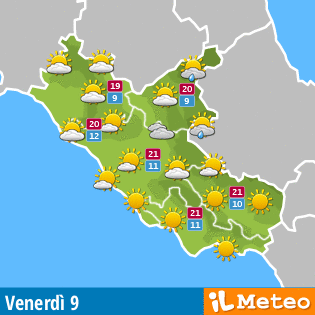di CARLO CANNA
Il 18 ottobre del 1615, dopo un lungo viaggio iniziato due anni prima dal porto di Ishinomaki, in Giappone, il samurai Hasekura Rokuemon Tsunenaga, ambasciatore del daimyo Date Masamune di Sendai, giunge a Civitavecchia, porto dello Stato Pontificio e, dopo un breve soggiorno, approda a Roma per incontrare il Papa. Lo scopo del diplomatico nipponico è duplice: aprire un trattato commerciale tra Giappone e Messico e, al contempo, rimarginare una vecchia ferita che si era creata con la Chiesa quando, il 5 febbraio del 1597, su ordine dello shogun della corona giapponese, ventisei cristiani vennero barbaramente uccisi su un’altura presso Nagasaki. Stiamo parlando di quei religiosi che avevano fatto tanti proseliti in terra nipponica con l’arrivo dei gesuiti guidati da Francesco Saverio e, successivamente, dei francescani.
Oggi, nella chiesa ottocentesca dei Santi Martiri Giapponesi, a Civitavecchia, possiamo rivivere quei tragici momenti attraverso gli affreschi realizzati negli anni ’50 del Novecento dal pittore giapponese di fama internazionale Luca Hasegawa. Si tratta di cinque riquadri del coro (la parte terminante della chiesa, contenente l’altare maggiore), più precisamente del presbiterio, che raffigurano le scene dell’arresto e della crocifissione dei ventisei martiri: sei francescani (di cui quattro di origine spagnola, un messicano e un indiano di origine portoghese), tre gesuiti giapponesi e diciassette terziari francescani (laici) giapponesi. Il momento culminante di tale rappresentazione è quello del martirio di san Pierbattista, san Francesco Blanco e san Ludovico Ibaragi, raffigurato nel quadro centrale. Ma, entrando nella chiesa dedicata ai martiri giapponesi, a rapire immediatamente lo sguardo dell’osservatore, sono pure cinque figure che Hasegawa dipinse sulle pareti della volta e, tra queste, in particolare, colpisce quella centrale di una Madonna con Bambino, nota localmente come la “Madonna con il kimono”, segnalata da fonti autorevoli come l’unica testimonianza del genere esistente in tutta Europa. A descriverla è lo stesso autore attraverso i suoi appunti:” Madonna con Bambino, costume di Signora di alta società di l’epoca XVI Secoli”. Più dettagliatamente, entrambe i soggetti, sono ritratti non solo con i tradizionali abiti del Sol Levante, ma anche con tratti somatici inequivocabilmente orientali. L’immagine della Madonna è raffigurata in piedi sopra un tappeto verde fluttuante mentre sorregge il bambino che tiene in mano una colomba. Entrambe presentano la distintiva aureola (attributo figurativo diffuso anche nell’arte sacra dell’Estremo Oriente) a sottolinearne la santità, dettaglio ulteriore che si inserisce all’interno di questo straordinario connubio di elementi appartenenti a culture molto diverse tra loro. Quando il cardinale Celso Costantini, profondo conoscitore dell’arte sacra, il 10 ottobre del 1954 si recò nella chiesa francescana civitavecchiese per benedire le opere realizzate dal pittore nipponico, definì l’affresco della Madonna come una delle più belle immagini di Maria dipinte nei tempi moderni.
In occasione della cerimonia che si tenne a Civitavecchia il 6 novembre del 1954 per il conferimento della cittadinanza onoraria a Luca Hasegawa, l’artista nipponico donò all’amministrazione comunale un modello a grandezza naturale - in gergo artistico detto “cartone” - che aveva realizzato della Madonna con Bambino raffigurata nella chiesa dei Santi Martiri Giapponesi, nota localmente come la “Madonna con il kimono”. Purtroppo di questo prezioso omaggio alla città, tra gli anni Sessanta e Settanta, si persero “misteriosamente” le tracce, privando così Civitavecchia di un bene che era destinato ad appartenere all’intera comunità.
Ma tornando agli affreschi della volta della chiesa, sopra l’immagine della Madonna, possiamo notare il simbolo della Trinità, raffigurato come un occhio racchiuso all’interno di un triangolo e, ai lati di Maria, due figure emblematiche legate fortemente alla storia della parrocchia francescana di viale Vittoria: San Francesco Saverio e San Francesco d’Assisi. Il quadro delle figure della volta si completa con due personaggi che appartengono alla storia della città: Santa Fermina, patrona di Civitavecchia ed Amelia, e Hasekura Tsunenaga, il samurai sbarcato in città nel lontano 1615 partendo da Ishinomaki, città gemellata con Civitavecchia dal 1971 (venti anni più tardi, nel 1991, in viale Marconi, verrà eretta una statua in bronzo del samurai per celebrare il 40° anno di gemellaggio tra le due città portuali). Un dettaglio curioso della volta in cui si inseriscono le cinque figure appena descritte, è il colore, un blu cobalto di rara bellezza che l’artista acquisì direttamente in Francia.
Secondo uno studio pubblicato nel 2014 è interessante notare come nel lavoro realizzato da Hasegawa all’interno della chiesa civitavecchiese, ricorra più volte il numero cinque, ben radicato nella filosofia cinese (e, dunque, giapponese), nella tradizione cristiana occidentale (basti pensare alla simbologia eucaristica dei cinque pani distribuiti da Gesù o al numero delle ferite che gli vennero inferte durante la crocifissione) e in quella orientale (riferita ai cinque inchini di ringraziamento con segno della croce, tradizionali dei cristiani cinesi, concessi al martire francescano San Giovanni Lantrua). Lo troviamo infatti non solo nel numero delle figure della volta e nella suddivisione degli affreschi del coro, ma anche nei cinque oculi dipinti negli archi delle sei cappelle laterali, anch’esse splendidamente affrescate dal pittore giapponese.
Il sogno di Hasegawa era quello di ultimare la propria opera nella chiesa realizzando nuove decorazioni, ma tutto questo non avvenne, né prima, né dopo la sua scomparsa. E’ doveroso ricordare che l’artista non richiese mai alcun compenso per il proprio lavoro, vissuto costantemente in uno stato di profonda spiritualità come possiamo notare nel suo autoritratto, con le mani giunte in segno di preghiera, raffigurato su uno dei quadri del coro. Resta celebre la sua frase: ”ogni pennellata è la mia preghiera”.
Luca Hasegawa si spense a Roma nel luglio del 1967, all’età di settant’anni, dopo essere stato colpito da un infarto. Per sua espressa volontà, i funerali si celebrarono nella chiesa dove tanto aveva lavorato restituendoci uno straordinario esempio di sincretismo culturale che rappresenta un messaggio - oggi, più che mai attuale - di pace universale fondato sul dialogo interreligioso, ed un unicum nella storia dell’arte sacra.
Riferimenti bibliografici: Luci sulla città d’incanto (2). Una chiesa e il suo pittore: la verità, la gloria e l’amore (2009) di Costantino G. Forno; Poi che la gente poverella crebbe. Presenze francescane nella diocesi di Civitavecchia-Tarquinia (2014) di Giovanni Insolera