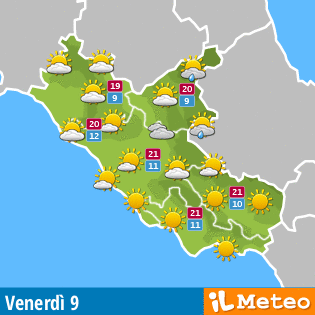di CARLO CANNA
CIVITAVECCHIA - Edificata alla fine del XVII secolo, la Chiesa di Santa Maria dell’Orazione, conosciuta anche come “Chiesa della Morte”, in passato “S. Rotonda del Suffragio”, rappresenta la più antica chiesa di Civitavecchia tra quelle risparmiate dai bombardamenti della seconda guerra mondiale. La storia della chiesa è rimasta da sempre legata indissolubilmente alla presenza della Confraternita dell’Orazione e Morte, detta anche dei “fratelli della buona morte” (ossia la morte cristiana). Lo stemma della confraternita è rappresentato da un teschio con le tibie incrociate, tra due clessidre che simboleggiano l’inesorabilità dello scorrere del tempo, sormontato dalla croce con i simboli della passione di Cristo. Sotto il teschio, stilizzato, il sacro monte. Detto simbolo lo ritroviamo negli antichi documenti e sulla mantellina nera dell’abito che ancora oggi viene indossato dai Confratelli nelle celebrazioni liturgiche e durante le processioni. L’operato svolto dalla Confraternita della Morte si distinse principalmente in due attività: quella di dare degna sepoltura e suffragio ai cadaveri dei defunti poveri e dei morti abbandonati nelle campagne o dispersi in mare e quella di poter liberare annualmente un condannato a morte in occasione della Pasqua a seguito di un provvedimento emanato da Papa Pio VI nel 1775. L’organizzazione interna era rappresentata dalla figura centrale del “Provveditore dei morti”, incaricato di dirigere il compito del seppellimento effettuato dai Confratelli vestiti col saio e il cappuccio nero, accompagnati da un sacerdote e dai portatori della croce, del lampioncino e del cataletto. La pratica del “Mortuus sepelitur” trovò la sua sede più originale nella cappella della chiesa dedicata a S. Raffaele, detta anche “Cemeterio”, poiché adibita a sepolcreto per i “morti di campagna”. Si trattava di uno spazio costruito intorno al 1756, a imitazione di strutture simili esistenti a Roma, a cui si accedeva dalla cappella di S. Michele Arcangelo passando attraverso un ampio arco (attualmente murato ndr) protetto da una cancellata di ferro. A partire dalla prima metà del XIX secolo tale ambiente si sarebbe presentato in questo modo agli occhi dei visitatori: ai lati dell’arco d’ingresso erano poste simmetricamente due nicchie in cui erano custoditi in posizione diritta due scheletri vestiti in nero abito monacale; le pareti erano completamente ornate con ossa e crani umani e sul pavimento erano poste due lapidi sepolcrali; sulla parete a destra dell’altare - sormontato da timpano e da una tela raffigurante l’Arcangelo Raffaele - vi erano due colonne con arco sovrastante che fungevano da proscenio ad un palco in cui venivano presentate rappresentazioni sacre con episodi tratti dalla Bibbia o collegati all’attività della Confraternita. Vi erano poi altre due nicchie poste simmetricamente ai lati dell’altare, all’interno delle quali erano disposti gli scheletri nudi e in posizione diritta di Padre Bartolomeo Pepino - chiamato familiarmente “Peppino” - e “Gavina” - un personaggio di cui non si conosce l’origine del nome - al di sotto dei quali si trovavano due targhe che recitavano rispettivamente il “memento mori” nel seguente modo: “noi siamo scheletri/tu scheletro sarai/fa bene a tutti noi/che un dì lo troverai” e “ tu che guardi su/ero io come sei tu/tu sarai come son io/fai del bene e pensa a Dio”. Sappiamo che in particolare una visita allo scheletro di “Peppino” era d’obbligo per i molti fedeli che si rivolgevano a lui come ad un santo, arrivando persino a trasformare una autentica forma di devozione in superstizione, motivata dalla speranza di poter ricevere dal religioso particolari lumi cabalistici per il gioco del Lotto. La Confraternita mantenne il diritto di seppellire all’interno della cappella fino al 1870 e circa settant’anni più tardi c’era ancora l’usanza di celebrare l’Ottavario di preghiere per i defunti. Nel 1944 alcuni soldati americani si introdussero più volte nella chiesa asportando oggetti sacri e persino le ossa del “Cemeterio”. Nel 1948, le spoglie mortali rimaste all’interno della cappella, furono trasportate, dopo una semplice cerimonia funebre, nell’ossario del cimitero comunale.
Dopo oltre tre secoli di storia, una traccia della “presenza” di coloro che in questa chiesa trovarono l’eterna dimora è sopravvissuta anche attraverso alcune leggende che sono state tramandate nella memoria locale su questo suggestivo luogo di culto: c’era ad esempio chi sosteneva di sentire strani rumori di catene provocati dalle anime del Purgatorio o chi riteneva addirittura di aver visto un sacerdote, deceduto da tempo, uscire da un muro e pregare recitando il breviario…(1. Continua).