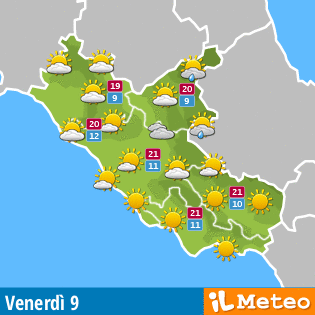ENRICO CIANCARINI
CIVITAVECCHIA – Lo spiritismo era così diffuso a Civitavecchia nei primi anni del secolo scorso che monsignor Luca Piergiovanni, vescovo delle Diocesi unite di Corneto e Civitavecchia (1917-1926), in occasione della Quaresima del 1919, inviò “al suo Venerabile Clero e Dilettissimo Popolo” la Lettera pastorale “Lo Spiritismo”, datata 2 marzo, che si apre con queste pesanti parole di denuncia:
“Nel breve tempo da che mi trovo in mezzo a voi, fratelli e figli carissimi, ho dovuto constatare che, specialmente nelle città, molto male fa e molto bene impedisce il demonio per mezzo dello spiritismo, il quale è diffuso più di quanto a prima vista può sembrare, e tiene molti fedeli lontani dalle pratiche della vita cristiana e in prossimo pericolo di perdere la fede.
Credo perciò dovere mio di Vescovo far conoscere ai fedeli e a tutte le persone che vogliono conservarsi oneste, i gravissimi danni dello spiritismo.
Non è certo mia intenzione parlarne ampiamente, confutare uno per uno tutti gli errori condensati in libri, riviste, giornali spiritistici, o fatti circolare fra il popolo. Sarebbe anche impossibile e fuor di luogo in una breve lettera pastorale. Mi basta farvi toccare con mano che lo spiritismo è opera diabolica, che nessun vantaggio possiamo riprometterci dal praticarlo, ma solo danni gravissimi per l’anima e il corpo; che per conseguenza ognuno ha stretto obbligo di tenersene lontano”.
La Lettera pastorale di monsignor Piergiovanni prosegue suddivisa in vari paragrafi: Causa preternaturale; Non sono le anime dei morti; Vera causa: i demoni; Obiezione 1: è un conforto conversare coi suoi cari; Obiezione 2: non c’è nulla di male!; Obiezione 3: dicono tante cose buone!
Alla fine la condanna: il vescovo ricorda che la Congregazione del S. Offizio il 24 aprile 1917 aveva decretato che “a conversazioni o manifestazioni spiritistiche di qualunque genere, ottenute col Medio o senza Medio, con o senza uso dell’ipnotismo, anche se si presentano sotto aspetto di onestà o di pietà, non è lecito assistere, né interrogando le anime o gli spiriti, né ascoltando le risposte, né come semplici spettatori, neppure con la protesta tacita o espressa di non volere aver parte alcuna con gli spiriti maligni”.
Partecipare allo spiritismo è grave peccato, si raccomandava il vescovo che chiude la sua Lettera stabilendo che “i parroci, in una o più domeniche di Quaresima, leggano e, occorrendo, spieghino al popolo la presente lettera pastorale” (grazie a don Augusto Baldini, archivista della Diocesi, per avermi messo a disposizione questo documento di difficile reperimento).
A Civitavecchia operavano in quegli anni gruppi di spiritisti con numerosi adepti fra cui Francesco Scotti, sindaco della città per alcuni anni, fondatore dell’Associazione archeologica Centumcellae:
“Nei primi giorni dello scorso dicembre è morto a Civitavecchia il cap. Francesco Scotti, un appassionato sperimentatore delle medianità che venivano in suo contatto e del quale i lettori di Luce e Ombra” ricorderanno una relazione di sedute tiptologiche pubblicate nel corso dell’anno 1918. [omissis]
Questo uomo che soprattutto ebbe cari i nostri studi e il problema della nostra immortalità, della quale non dubitò un solo istante. È morto con serena e piena coscienza di spiritualista, disponendo dei suoi funerali nella guisa più modesta, senza vari onori e querimonie convenzionali. Aveva sessantanove anni di età”.
Anche suo nipote, Eugenio Scalfari, in Racconto autobiografico (2014), lo ricorda “appassionato di spiritismo e collaborò ad alcune riviste che si occupavano di quell’argomento allora molto in voga”.
I ricordi del grande giornalista hanno stimolato la mia curiosità di scoprire qualcosa sullo spiritismo a Civitavecchia nei primi decenni del ventesimo secolo e mi hanno spinto a dedicare una ricerca a Francesco Scotti e a i suoi scritti sull’argomento. Ho preso perciò contatto con la Fondazione Biblioteca Bozzano De Boni, con sede a Bologna, che edita la rivista “Luce e Ombra”, il cui primo numero uscì nel dicembre 1900. Grazie alla cortesia e alla disponibilità dell’architetto Gianfranco Cuccoli, curatore della biblioteca e dell’archivio della Fondazione, ho ricevuto gli articoli che lo Scotti pubblicò su quella rivista dedicata alla ricerca psichica e il necrologio a lui dedicato nel 1924.
L’ex sindaco di Civitavecchia moriva il 1o dicembre 1923, cento anni fa.
Su “Luce e Ombra”, Francesco Scotti pubblicò tre articoli durante il 1918, ultimo anno di guerra, intitolati “Sedute tiptologiche”. La tiptologia (dal greco battere un colpo) è la forma più semplice di spiritismo, quella che si fa intorno ad un tavolo che alzandosi batte dei colpi che vengono interpretati dai presenti.
Il primo articolo dello Scotti sulla rivista “Luce e Ombra” ha un’introduzione della direzione della rivista che presenta il “cronista” delle sedute spiritiche civitavecchiesi: il capitano Francesco Scotti “ex-sindaco di Civitavecchia, e attuale presidente della Camera di Commercio, il quale, per questa sua qualità ha potuto – anche più facilmente – procurarsi i documenti ufficiali in appoggio”.
La parola o meglio lo scritto passa poi allo Scotti che presenta il medium protagonista delle sedute:
“Il medium, sig. Achille Carnevali conta ora 45 anni; è intelligente ma di mediocre cultura, non avendo fatto che la seconda elementare. Teneva un negozio di mercerie che dovette cedere e si cercò un impiego; egli non crede – almeno così afferma – che si possa comunicare coi morti; si presta di mala voglia alle sedute, è onestissimo e non accetta retribuzione”.
Le sedute spiritiche si svolgevano nell’ufficio dello Scotti e vi partecipavano sempre i signori D. Reali, P. Jaforte, e spesso i signori D. Legnani e G. Inesi. Talvolta intervenivano “professori dell’Istituto, magistrati, impiegati, professionisti, ecc.”.
La cosa forse più singolare della vicenda è che le riunioni medianiche attraverso le quali lo “spirito” di un morto entrava in contatto con i vivi, grazie a dei colpi battuti su un tavolo, si svolgevano nell’ufficio del sindaco di Civitavecchia e cosa ancor più sorprendente è che il sindaco, cioè Francesco Scotti poi scriveva ai suoi colleghi in giro per l’Italia per ottenere conferma del decesso e degli altri dati rivelati dallo “spirito” con cui erano entrati in contatto.
Scotti descrive così le riunioni:
“Quando le sedute erano calme, il medium fumava o parlava con qualcuno del circolo ed era sempre molto distratto. Talvolta invece il tavolo medianico sembrava animarsi, aveva dei tremiti espressivi, quasi di commozione; il medium impallidiva, accusava sensazioni inesplicabili, mentre un sudore freddo gli scendeva dalla fronte; egli toglieva allora le mani dal tavolo”.
Lo Scotti garantiva per il medium Achille Carnevali affermando che “escludo in modo assoluto che le notizie avute per tale via potessero essere in alcun modo note in precedenza al medium o ai presenti sia nella loro totalità che nei loro particolari”.
La prima seduta spiritica avvenne la sera del 5 gennaio 1913, presenti oltre al medium, lo Scotti, Reali, Jaforte e Legnani. Lo “spirito” che entrò in contatto con il gruppo civitavecchiese era di una donna: “Elisa Gasparini, morta a Milano 16 anni or sono; fui amata compagna del mio Piave”.
Francesco Maria Piave fu il librettista principale di Giuseppe Verdi, personaggio molto noto in Italia. Elisa Gasparini, cantante nata a Gorizia, era sua moglie.
Il sindaco Scotti scrisse al Comune di Milano da cui ricevette conferma di quanto detto dallo “spirito”.
Nelle sedute descritte dallo Scotti, si materializzarono quasi sempre “spiriti” la cui vita e morte era possibile rintracciare nei giornali dell’epoca, cosa che sono riuscito a fare io dopo centodieci anni.
Nel terzo articolo pubblicato da “Luce e Ombra” il personaggio più interessante e noto è Luigi Manzotti. Si manifesta in più sedute con “lo stesso medium, gli stessi assistenti, dirige F. Scotti”.
Consultando il Dizionario Biografico degli Italiani (DBI, volume 69, 2007) alla voce MANZOTTI Luigi, apprendiamo che lo “spirito” che si presenta al gruppo civitavecchiese la prima volta il 18 ottobre 1914, è un personaggio molto famoso in Italia in quegli anni: mimo, danzatore e infine fra i più affermati coreografi nell’Italia umbertina. Nella scheda biografica, compilata da Claudia Celi, leggiamo che fu il “vate dell’immaginario della nuova classe propulsiva borghese e industriale, il Manzotti fu il riconosciuto cantore del Regno italiano nato alla fine del processo risorgimentale sotto la guida della monarchia sabauda”. Nella sua carriera gioca un ruolo particolare la nostra città: infatti il giovane coreografo nativo di Milano colse il suo primo successo qui, come è narrato nelle Conversazioni di Doctor Veritas di Leone Fortis (1890): “Quel ballo andò difatti in scena al teatro Traiano di Civitavecchia, nell’estate del 1865, e si intitolava Il Moro riconoscente. Era in tre atti. Fu quello il suo primo successo coreografico. Il ballo piacque molto – specialmente per la energia con cui Manzotti eseguiva la parte del protagonista. V’era un suo gesto di rivolta e di sfida che faceva trasalire il pubblico ogni sera”.
I nostri spiritisti forse lo vollero ricordare in quelle bizzarre sedute che si svolgevano al Comune.