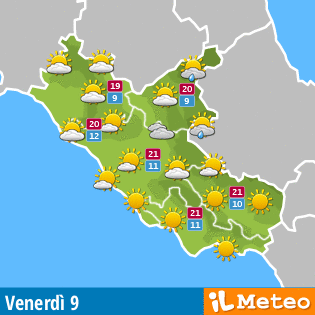di CARLO CANNA
“Gioia ho d’aver conosciuto le Terme cui Tauro dà il nome! Distan tre miglia: lungo non è né grave. Ivi, non fa sgradevoli i fonti alcun gusto d’amaro, né mai sulfurea nube tinge i tepenti rivi. Schietto hanno odor, son dolci al palato, e l’incerto bagnante non sa in qual luogo ei possa linfe trovar migliori. Ove a la fama si creda, lì un toro scoprì quella vena, e i caldi a noi lavacri diede, raspando il suolo, come fa allor che a pugna preluda e, con prona cervice, su duro tronco, bieco le corna arroti” (De Reditu suo, V sec. d.C.). Con queste parole, il poeta romano Rutilio Claudio Namaziano in visita a Centumcellae (l’odierna Civitavecchia) e alle Terme Taurine nel 416 d.C., interpreta l’origine del nome dato al complesso termale con una antica leggenda, quella di un toro che avrebbe raspato la terra, come fanno i tori prima di iniziare una lotta, facendone scaturire una sorgente d’acqua calda sulfurea dalle straordinarie proprietà. E’ possibile che a questa leggenda possa legarsi un interessante reperto archeologico, rinvenuto nei pressi delle Terme Taurine, come suggerito dal grande illuminista civitavecchiese Gaetano Torraca nelle sue “Novelle Letterarie” del 1796. Si tratta di una testa marmorea di toro, quasi a grandezza naturale, che il Torraca identifica correttamente come una bocca di fontana sulla base della presenza di un foro per la fuoriuscita dell’acqua. Tuttavia, occorre precisare che per trovare un legame tra la testa taurina (oggi andata perduta) e la leggenda riportata da Namaziano bisognerebbe dimostrare che un simile reperto rappresenti una particolarità del sito termale civitavecchiese. E questo non è stato ancora fatto. Ma tornando alla leggenda ci si può chiedere: è possibile che la prima fonte di ispirazione possa essere stata l’osservazione di un fatto reale? La risposta, a detta dello scrivente, è assolutamente affermativa. Infatti, la possibilità che un grande animale come un toro o un cavallo, raspando il terreno possa determinare la fuoriuscita di acqua dal sottosuolo, è del tutto realistica e il dato mi è stato confermato da diverse persone in qualità di testimoni diretti del fenomeno nei pressi della sorgente termale della Ficoncella, poco distante dalle Terme Taurine (in questo caso per la precisione si trattava di un cavallo). Il tema, peraltro, è ricorrente nella letteratura antica e lo stesso Namaziano, subito dopo aver descritto il passo del toro sopra citato, prosegue con le seguenti parole: “Non abbian solo i Greci dè grandi miracoli il vanto, se un animal fu padre del Fonte d’Elicona, chè, simile a quel fonte, scavato alle Muse da equina unghia, crediam nascesse pur questa polla chiara”. Naturalmente simili racconti si tingono di elementi leggendari e questo può esserci utile per cogliere nuovi spunti di riflessione su quanto riportato dal poeta romano. Infatti, da questo racconto si evince chiaramente il rapporto di causa ed effetto tra l’immagine del toro, probabilmente assimilato a Giove, e la descrizione di un fenomeno naturale, la sorgente d’acqua termale. Secondo il poeta greco del VII secolo a.C., Pisandro, alle calde acque termali si dava l’appellativo di Ercolane poiché si riteneva che simili acque fossero state fatte scaturire da Minerva nei pressi di una spiaggia, per dare ristoro ad Ercole durante il suo viaggio verso Erice e lo stesso Namaziano, citando l’amico e poeta Messalla, che pure aveva composto una poesia sulle Terme Taurine, ci riferisce l’antica credenza secondo la quale le cavità da cui scaturivano queste acque erano paragonabili agli “antri” delle Muse. Questi esempi mostrano come per gli antichi le misteriose forze della natura richiedevano un’interpretazione divina per essere comprese e tutto questo era ancor più vero per quei fenomeni naturali che potevano colpire di più l’immaginazione, come le sorgenti termali, che da un punto di vista geologico - assieme ai vulcani, i geyser e le fumarole - sono i fenomeni superficiali più rilevanti che manifestano il calore contenuto all’interno della Terra. Infine, vale la pena di spendere due parole su un ulteriore chiave di lettura che ci viene offerta dalla leggenda di Namaziano attraverso la descrizione di un animale “divino” che fa scaturire una sorgente termale rivelatasi immediatamente curativa, interpretabile come un riconoscimento da parte degli antichi dei principi benefici di tali acque non solo sulle persone, ma anche sugli animali. Questa ipotesi, suggerita dalla ricercatrice Maddalena Bassani dell’Università di Padova, non trova tuttavia ulteriori e solide conferme nella documentazione archeologica in nostro possesso proveniente dalle Terme Taurine. Sappiamo infatti che nell’area di riferimento l’utilizzo di acqua termale su animali a scopo terapeutico venne adottato con certezza solo nel XVIII secolo grazie, ancora una volta, alle preziose informazioni forniteci dal Torraca nel saggio “Delle antiche Terme Taurine esistenti nel territorio di Civitavecchia” del 1761. Tuttavia, è lecito pensare che tale pratica fosse adottata dagli allevatori di bestiame, almeno a partire dall’Età del Bronzo, quando sappiamo che nel comprensorio di Civitavecchia, o meglio nel cosiddetto “arco del Mignone”, si sviluppa l’allevamento delle tre principali categorie di animali domestici (bovini, ovicaprini e suini) e con esso, conseguentemente, anche il rischio aumentato di trasmissione di infezioni tra i capi di bestiame che poteva così essere scongiurato anche attraverso lo sfruttamento delle proprietà curative e purificanti dello zolfo contenuto nelle acque termali.
© RIPRODUZIONE RISERVATA