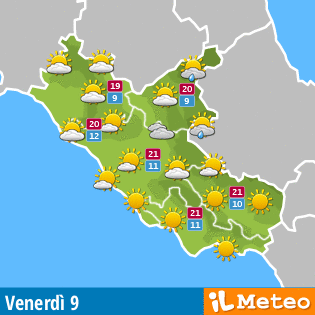di CARLO CANNA
In quel Settecento passato alla storia come il “secolo dei lumi”, che vede contrapporre la centralità del sapere scientifico alle metafisiche tradizionali, si assiste ad un profondo rinnovamento nelle più diverse discipline della conoscenza. Tra queste, in campo biologico, si afferma anche una “nuova” teratologia, in realtà erede degli studi seicenteschi condotti dallo studioso italiano Fortunio Liceti, fondata su un metodo di indagine di tipo medico-scientifico. In questo contesto, si inserisce la figura poliedrica di Gaetano Torraca, medico e scienziato civitavecchiese, che in una lettera indirizzata al cardinale Stefano Borgia in data 13 settembre 1779 e pubblicata due mesi dopo sul numero XXI della rivista “Antologia”, riporta una dettagliata relazione intitolata “Mostro Umano”. Si tratta dello sfortunato caso di un bambino nato ad Allumiere il 27 agosto di quell’anno, di cui il Torraca dice di essere venuto a conoscenza grazie al collega Gio. Francesco Adriani, medico di Tolfa, e di averne ricevuto conferma dall’Arciprete delle Allumiere Don Domenico Giordani. Questa è la descrizione parziale che ne fa il medico civitavecchiese: “il feto era in ogni sua parte benissimo formato, e la di lui mostruosità consisteva tutta nel volto. Respirò affannosamente in tutto il breve tempo di sua vita…”. Riguardo al volto sappiamo che il naso era del tutto mancante e la bocca “era naturalmente conformata; se non che le labbra sembravano risultanti da un semplice traverso taglio fatto sulla cute”.
Ma, l’attenzione del Torraca, si concentra maggiormente sulla regione oculare di cui se ne riporta un breve estratto: “ L’occhio del nostro Ciclope si è osservato non essere in realtà unico, ma essersi bensì li due occhi sviluppati nell’embrione, vicinissimi uno all’altro…Entro dell’orbita si sono, per così dire, immedesimati li due bulbi…”. Dall’accurata descrizione fornita dal medico - a detta dello scrivente - è possibile identificare facilmente la patologia in questione con una forma di oloprosencefalia, una rara malformazione del sistema nervoso centrale del feto causata da fattori congeniti (infezioni prenatali, assunzione di farmaci in gravidanza, diabete mellito materno, ecc.) e genetici (in particolare trisomia 13). Ma il nostro Torraca come interpretò questo strano fenomeno nella seconda metà del XVIII secolo? Da uomo di scienza del suo tempo sappiamo che si avvalse del sempre valido criterio basato sull’osservazione del caso (se pur indiretta, attraverso il rapporto fornitogli dall’Adriani) messo a confronto con quelli riportati in letteratura da altri studiosi, senza cedere a teorie di matrice popolare, all’epoca ben radicate nell’immaginario collettivo, come quella ben descritta in questo passaggio riferito alla nascita di una bambina affetta da una rara malformazione alla testa: la mamma della bimba dice di aver avuto una terribile paura all’aspetto di una Civetta nel corso della sua gravidanza. Difatti questa testa ha una certa tal qual somiglianza con quella dell’uccello da noi mentovato” (da “Antologia” n. XVI dell’ottobre del 1779).
Rifacendosi agli studi di Carlo Bonnet pubblicati nell’opera “Contemplazione della natura” (1787), il medico civitavecchiese si concentra sulla realtà materno-fetale e interpreta l’insolita patologia del bambino di Allumiere come il risultato di una “compressione” di “minutissime particelle” avvenuta allo stadio embrionale. Sull’origine di questa, di seguito, esprime le seguenti ipotesi: ”qual poi si fosse la cagione di tal disordine non è facile l’indovinarlo. Forse fu preceduta la fecondazione del feto da qualche idatide, o sia acquoso tumore nell’utero della madre, e forse ancora nell’ovulo stesso, dopoche fu fecondato. Crebbe in tal senso quel tumore, e crebbe col feto, e formossi con esso l’idrope, che realmente si vuotò prima del parto nello spargimento dell’enorme quantità di acqua dalla matrice”. Il Torraca infine puntualizza di non aver potuto effettuare un esame autoptico sul corpo del bambino finalizzato allo studio delle strutture anatomiche correlate all’apparato visivo poichè “non fu possibile vincere la ripugnanza del pio genitore, il quale sdegnò, che disumata restasse la mostruosa sua prole”.
In conclusione, questo documento storico ci restituisce uno straordinario esempio sui limiti della scienza e, al contempo, sul tentativo dell’uomo di superarli, con lo stesso impegno e la stessa passione che ancora oggi mette a dura prova medici e scienziati nella continua lotta a patologie che non hanno ancora una cura e, talvolta, nemmeno un nome.
© RIPRODUZIONE RISERVATA