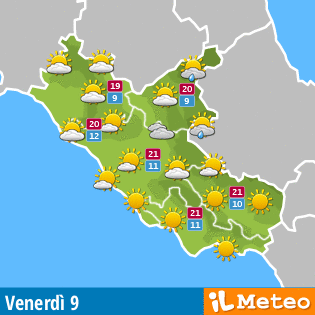di CARLO CANNA
CIVITAVECCHIA - Esiste un filone di successo nel cosiddetto “cinema di genere” che vanta una lunga tradizione dedicata alle grandi civiltà del passato, soprattutto quella greca, romana ed egizia, mentre si contano ben pochi film che raccontano il mondo etrusco. Infatti, escludendo i documentari sugli Etruschi realizzati in gran parte negli anni Ottanta (vedi quelli di M. Becattini e F. Quilici - M. Maranzana), si ricordano solo gli storici “Le vergini di Roma”(1961) di V. Cottafavi - C. L. Bragaglia e “Il colosso di Roma-Muzio Scevola” (1964) di G. Ferroni, entrambe narranti lo scontro tra la civiltà etrusca e quella romana, e alcuni “archeo-thriller”, ambientati nel presente, tra le antiche vestigia etrusche (e ahimè, spesso, non solo quelle), che fanno riferimento in modo più o meno fantasioso alla parte più oscura del popolo legato profondamente al culto dei morti. Tra questi ultimi, andando a ritroso nel tempo, troviamo “La maschera etrusca” (2007) di T. Nicolau, “Ossidiana” (1992) di M. Felici, “Assassinio al cimitero etrusco” (1982) di C. Plummer e infine, “L’Etrusco uccide ancora” (1972), di A. Crispino, una tra le pellicole di maggior successo del genere, girato nella necropoli della Banditaccia di Cerveteri, una delle più monumentali dell’intero mondo mediterraneo, e in altre suggestive location tra Spoleto,Tarquinia, Frascati e Montefiascone. La trama del film è incentrata sulla figura di un enigmatico e pericoloso assassino che uccide giovani coppie ispirandosi agli inquietanti affreschi scoperti da un archeologo all’interno di una tomba etrusca in cui compare la figura demoniaca di Tuchulcha, il temibile guardiano etrusco degli inferi. La sua raffigurazione più nota è quella proveniente dalla Tomba dell’Orco di Tarquinia, dove presenta una chioma dalla quale escono serpenti, orecchie d’asino, grandi ali e infine – tratto distintivo presente in altre immagini attribuite a tale entità demoniaca – due serpenti tenuti tra le mani. Nell’immagine cinematografica di Tuchulcha, quella in cui il demone è raffigurato frontalmente, è interessante notare – a detta dello scrivente – la riproduzione pressochè totale dell’immagine di Tifone, raffigurata all’interno della tomba omonima, a Tarquinia, fatta eccezione per la presenza volutamente “offuscata” delle gambe serpentiformi al di sotto delle ginocchia, la posizione della mano destra che impugna una sorta di clava e naturalmente il volto che nell’immagine della Tomba del Tifone presenta in gran parte i tratti cancellati dall’azione del tempo. Volto, che peraltro nell’immagine cinematografica richiama solo vagamente la raffigurazione di Tuchulcha proveniente dalla Tomba dell’Orco per la presenza dei capelli “serpentiformi” e il profilo aquilino, se pur appena accennato, come si può ben notare nel primo piano della locandina del film. Nonostante le molteplici storture che si devono ad un “thriller parapsicologico”, il film è quello che si addentra maggiormente nell’affascinante mestiere dell’archeologo (con riferimento all’etruscologia) e, in tal senso, risulta particolarmente significativa la scena ambientata a Tarquinia, all’interno della splendida cornice di Palazzo Vitelleschi, sede del Museo Nazionale Etrusco, in cui si assiste ad un’accesa discussione tra l’archeologo e il custode della necropoli, dedito al traffico di reperti archeologici, una piaga purtroppo ancora tristemente attuale, apertamente denunciata all’interno di un film troppo spesso ingiustamente etichettato da una certa critica con il termine riduttivo di “b-movie”. Si tratta, in realtà, di un vero e proprio cult di inizio anni Settanta destinato a caratterizzare il genere negli anni successivi sotto diversi aspetti come il tema dell’omicidio legato al trauma infantile e le modalità con cui vengono rappresentati i delitti, a partire dalle musiche, del grande Riz Ortolani, colonna sonora degli stessi.