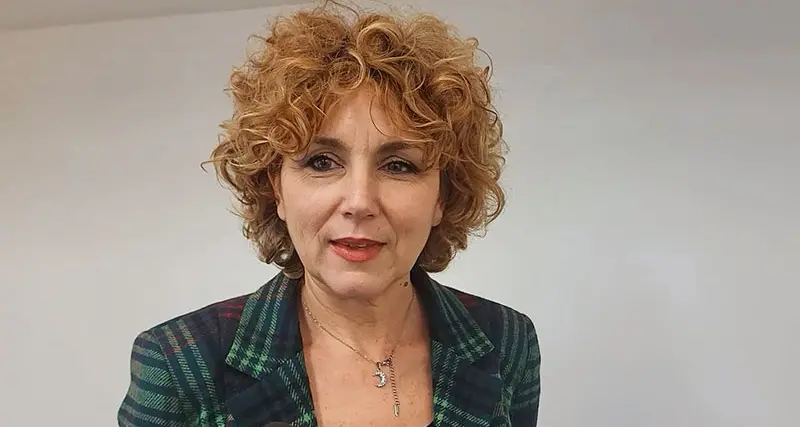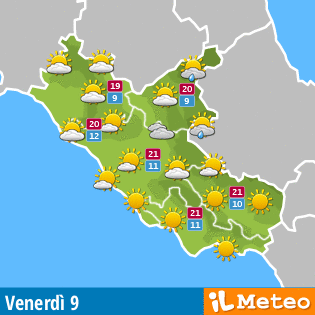ENRICO CIANCARINI
CIVITAVECCHIA – Recentemente, si è tornato a scrivere sulla storia plurisecolare dell’emigrazione italiana verso il Brasile. Il grande stato sudamericano oggi è il terzo paese al Mondo per la presenza d’immigrati d’origine italiana: trenta milioni pari al 22% della sua intera popolazione.
In questa ultracentenaria storia di dolore e di “saudade” (nostalgia in portoghese, la lingua ufficiale brasiliana) il nostro porto ha svolto per alcuni anni un ruolo di primo piano.
Il 9 febbraio 1837 abbandonava lo scalo civitavecchiese il brigantino napoletano “Madonna delle Grazie” di proprietà del capitano Balsamo. A bordo erano stipati sessantadue condannati per reati politici, fra essi anche ergastolani, provenienti dalla fortezza carcere di Civita Castellana. Alcuni di loro erano accompagnati dalle mogli (5) e dai figli (6 o 7). Con loro, il medico bolognese Gaetano Minelli, detenuto comune nel carcere di Spoleto, che era stato imbarcato per assistere i passeggeri nel lungo viaggio, presenti anche due farmacisti. Inoltre erano saliti a bordo una trentina di emigranti volontari, taluni con le famiglie. Con l’equipaggio, si raggiungeva il numero di 135 imbarcati. Al comando della spedizione, il governo pontificio aveva indicato il giovane capitano civitavecchiese Alessandro Cialdi, che già in precedenza aveva navigato e raggiunto le coste brasiliane nel 1832 con il piccolo bastimento “San Carlo” di proprietà di alcuni commercianti romani (Marina De Marinis, Cialdi, Alessandro, in Dizionario Biografico Italiano, volume 25, 1981).
L’idea di un trasferimento al di là dell’Atlantico dei condannati politici del papa, era balenata all’avvocato Carlo Armellini (il futuro triumviro della Repubblica Romana del 1849 con Mazzini e Saffi) che era ispirato da un precedente e analogo progetto ideato da tale Vincenzo Savi, un rappresentante del governo brasiliano, che si proponeva di deportare detenuti pontifici reclusi nella Fortezza di Civitavecchia, un progetto che poi non ebbe attuazione.
Il Brasile in quegli anni aveva un disperato bisogno di manodopera qualificata per il suo sviluppo economico e culturale. Nel saggio Un caso di emigrazione coatta: la “colonizzazione di Civitavecchia” (pubblicato in Italianos no Brasil, a cura di Antonio Mottin ed Enzo Casalino, 1999) sono registrati i lavori di alcuni degli emigranti forzati o volontari: 12 calzolai, 6 canepini, 5 falegnami, 5 sarti, 2 librai 2 barbieri, 4 ebanisti, 2 fornai, 2 macellai, e così via.
Il costo del viaggio era a carico dei detenuti che si erano impegnati a rimborsare lo Stato della spesa. La “Madonna delle Grazie” arrivò a Bahia il 22 aprile, dopo 73 giorni di navigazione. Quando in Brasile si seppe che a bordo del brigantino c’erano dei detenuti politici non si autorizzò lo sbarco che, dopo lunghe trattative, avvenne solo il 2 maggio.
Del centinaio di passeggeri del “Madonna delle Grazie” non tutti riuscirono ad integrarsi nella giovane società brasiliana e preferirono tornare in Europa. Altri si trovarono coinvolti in alcuni moti rivoluzionari poi repressi dalle autorità brasiliane.
Tornando a Civitavecchia, già nel 1834 l’incaricato d’affari brasiliano presso la Santa Sede aveva nominato Angelo Alibrandi viceconsole in città per occuparsi dei traffici commerciali fra lo Stato dell’America latina e lo Stato della Chiesa in transito per lo scalo tirrenico.
A cavallo fra fine Ottocento e primo Novecento, il porto di Civitavecchia fu centro d’imbarco per gli emigranti dell’Italia centrale e meridionale che volevano recarsi in Brasile. Da qui, le navi li trasportavano a Genova dove s’imbarcavano per lasciare definitivamente la Penisola.
Sul “Messaggero” appaiono numerose segnalazioni di queste dolorose partenze: “Sul Marsala, della Navigazione generale italiana, sono partiti oggi per Genova, ove imbarcheranno poi su altro piroscafo diretto al Brasile, circa 200 emigranti. Sono in maggior parte, delle provincie meridionali e romana. Spettacolo purtroppo desolante e triste” (24 settembre 1901). Pochi giorni dopo, il 9 ottobre, sono addirittura in mille ad imbarcarsi con destinazione Brasile. Il 13 è il turno di 500 emigranti provenienti dalla provincia romana, specialmente del viterbese. Il 25 ottobre 506 emigranti, sono “intere famiglie della Sabina e della provincia di Aquila”. Il 29 ottobre partono 500 emigranti “appartengono quasi tutti alla Ciociaria”. Il 9 novembre “altri 2 mila migranti per il Brasile”, sono viterbesi e ciociari.
Pagine dolorose della storia del nostro Paese quando erano i contadini romani, viterbesi, ciociari a varcare l’oceano per ottenere una vita migliore. Oggi Civitavecchia riceve immigrati dall’Africa e dall’Asia anch’essi alla ricerca di un mondo migliore, senza guerre, povertà e fame.