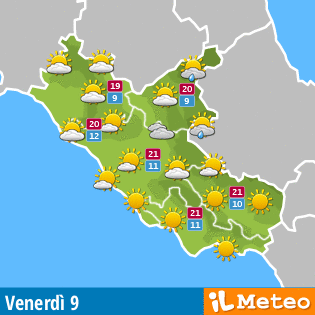di CARLO CANNA
CIVITAVECCHIA - La pesca del corallo mediterraneo o corallo rosso (corallium rubrum, Linnaeus 1758) nello specchio d’acqua antistante il tratto di litorale tirrenico compreso tra Tarquinia e Santa Severa, è un’attività ben documentata a partire dalle fonti classiche. Lo scrittore latino Plinio il Vecchio (23-79 d.C.), infatti, nel II capitolo del I libro della sua enciclopedica ‘‘Naturalis Historia’’, ci dice che tale attività era praticata attorno ai centri di Gravisca e Pyrgi e all’epoca sappiamo che la preziosa gemma purpurea era ricercata per il suo valore apotropaico (secondo il mito la nascita del corallo rosso non era altro che il risultato della pietrificazione di alghe e ramoscelli acquatici venuti al contatto con il sangue fuoriuscito dalla testa recisa di Medusa). Anticamente, era ampiamente consolidata la convinzione della natura vegetale del corallo che invece - lo ricordiamo - è una formazione calcarea prodotta dai cosiddetti ‘‘polipi’’, minuscoli animali coloniali forniti di otto tentacoli appartenenti al phylum dei celenterati (lo stesso gruppo che include attinie e meduse), da non confondere con i ‘‘polpi’’ che invece appartengono al phylum dei molluschi. Il primo a comprendere la vera natura del corallo sarà Filippo Finella, alchimista ed astrologo napoletano del 1600, ma solo nel 1723 il medico marsigliese Andrea Peysonnel riuscì a dimostrarne sperimentalmente l’appartenenza al regno animale. Nello stesso secolo, il Settecento, il Marchese Antigono Frangipane, nella sua ‘‘Istoria dell’antichissima città di Civitavecchia’’ (1761), ci dice che la pesca del corallo era un’attività ben remunerativa, praticata dai pescatori napoletani vicino alla Torre di Corneto (Tarquinia). Nel secolo successivo, l’Ottocento, il dato è confermato dallo storico Pietro Manzi attraverso le seguenti parole: «la pesca di questo litorale è sommamente produttiva...essa finalmente dà corallo di prima bellezza, e tale abbondante, che i pescatori ne ritraggono non men felici risultati di quello che si pesca a grandi rischi nelle inospitali spiagge dell’Africa» (da ‘‘Stato antico ed attuale del porto città e provincia di Civitavecchia’’, 1837). Anche Monsignor Vincenzo Annovazzi, nella sua ‘‘Storia di Civitavecchia. Dalla sua origine fino all’anno 1848’’, datata 1853, ci dice che a Civitavecchia ‘‘si fa pure la pesca del corallo a sei miglia di distanza verso il ponente non lungi dalla imboccatura del fiume Mignone; ma questa, come l’altra (riferita alla pesca delle alici e delle sardelle), viene esercitata quasi esclusivamente dai marinari napoletani’’. Una spiegazione sulla competitività dei pescatori napoletani è fornita sempre da Pietro Manzi, nel testo sopracitato: «i battelli pescherecci, così dette paranzelle, che vengono ad usurpare i nostri pesci, sono meglio costruiti, meglio equipaggiati, meglio regolati dei nostri. Minori sono per essi le spese di costruzione, di attrezzi, di mantenimento, perché frugalissima è la vita del marinaro di Napoli». La tecnica della pesca del corallo, adottata per secoli dalle marinerie mediterranee ed in particolare dalle barche ‘‘coralline’’ napoletane di Torre del Greco, consisteva nell’utilizzo di un attrezzo chiamato ‘‘ingegno’’, costituito da due grossi travi di legno legate in forma di croce di Sant’Andrea,appesantite al centro da una zavorra e ricoperte di stoppa e rete. Tale attrezzo veniva calato in profondità per il rastrellamento del fondo corallino e trainato per mezzo di funi fissate alla barca. La pesca del corallo, nell’area presa in esame in questo breve articolo, è continuata nel corso del Novecento fino ad esaurirsi progressivamente sul finire del secolo. Fino a tempi recenti, si trattava infatti di un’attività ancora praticata da subacquei professionisti che, in possesso di una regolare licenza, si immergevano nelle acque del litorale soprattutto a nord di Civitavecchia, nella millenaria ricerca della rinomata gemma purpurea.